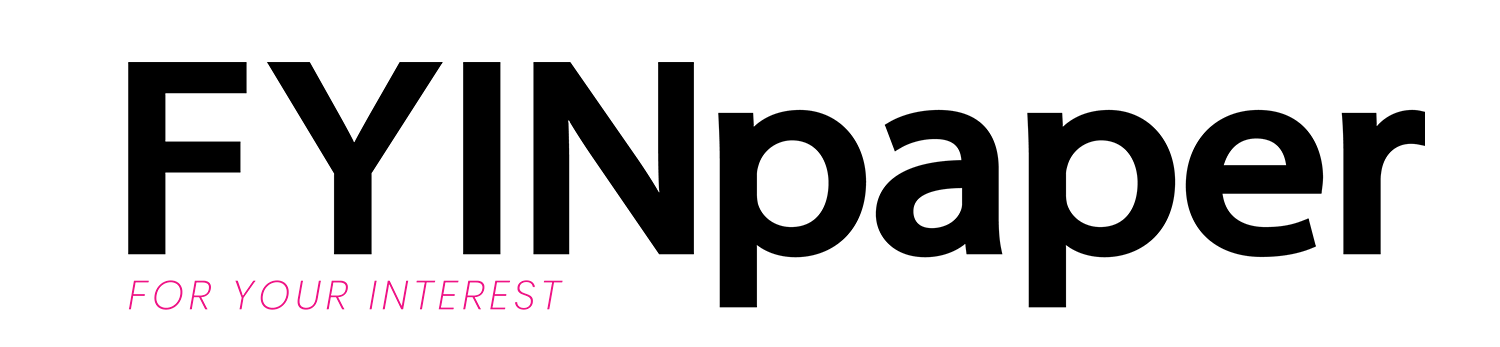Penso a una storia del pensiero costruita esclusivamente attraverso quella dell’arte e non attraverso quella della filosofia (arte visiva, certo, ma anche musicale e letteraria: la filosofia come ancilla artis). Questo proposito mostra una forte dose di ingenuità: non è possibile separare i due punti di vista e lo stesso linguaggio che sto usando in questo momento lo dimostra. Gli accenti però possono essere molto diversi, i fatti, le speculazioni critiche, le considerazioni esaminate, molto differenti.
Evidentemente il pensiero astratto, sistematico o umorale che sia (quest’ultimo imita il processo artistico, contraddittorio, anarchico, irrazionale, istintivo, si pensi per es. a un Nietszche o a un Cioran), può influire sul linguaggio artistico e sull’intuizione artistica, ma sempre in maniera indiretta e non diversamente da un male di pancia (superato, altrimenti non produci niente). Non bisogna fare compromessi con esso. Anche le considerazioni centrate sull’ideologia degli operatori o dei critici va possibilmente messa tra parentesi: non pertiene all’arte, perché è un sottoprodotto della filosofia.
L’etica pertiene all’arte? Certamente fa parte della vita dell’artista, nella misura in cui lui ha un rapporto con l’altro da sé, il figlio, il fratello ecc e più lontanamente il simile, ma soprattutto con una certa cultura, un’altra cultura ecc. L’etica rappresenta la zona promiscua della psiche dell’artista, perché lo mette in contatto proprio con punti di vista completamente ignorati dal proprio linguaggio elettivo, quelli della religione, della filosofia e della scienza.
Il pensiero artistico non può prescindere dal linguaggio, nel senso che pensa in lingua, quindi dalla storia di questo depositata nella memoria, prima di tutto degli operatori artistici viventi e poi negli oggetti artistici conservati e presenti (biblioteche, musei, e clouds digitali ecc) nel mondo.
Storia non significa sistematicità cronologica, ma solo mnemonica: Monna Lisa tramonta dietro le folle del Louvre e dietro il vetro (che la protegge dai vandali), ma non dietro le sue ottime riproduzioni, fintantoché conserva il proprio mistero, cioè qualcosa di imprendibile, incodificabile, intraducibile se non in linguaggi altri, cioè in altri prodotti artistici. Paradossalmente i baffi di Duchamp l’hanno fatta rivivere, richiamando l’attenzione su di lei, ma l’hanno uccisa, non con l’ironia dell’operazione (dissacrazione), bensì perché non hanno aggiunto alcunché di retinico alla sua immagine. Insomma il punto di riferimento deve sempre essere l’organo di ricezione e di trasmissione e non il cervello filosofico, ideologico, più o meno razionale, metaforico o alchemico.
Gli esempi per questo tipo di storia si sprecano, ma per rimanere in un campo stranoto, nel Rinascimento due vicende visive completamente opposte: Leonardo e Michelangelo. Il primo, attento alla natura in tutti i suoi aspetti, compreso quello della politica della forza (pensiamo alle sue macchine da guerra), arrivato fino ai nostri giorni ha influenzato l’arte che si serve senza scrupoli della tecnologia (solo per definire uno dei suoi aspetti); il secondo, erede della religiosità medioevale (anche se per l’inventore del Rinascimento parrebbe ai più che quel filo si fosse interrotto e non è), ha aperto per primo all’introspezione psicologica manieristica e poi è arrivato fino ai nostri giorni col bisogno del vuoto, del piazza pulita. Non scendo nei particolari, ma anche solo un breve esame del periodo della storia dell’arte degli ultimi cinquecento anni nel mondo occidentale potrebbe generare riflessioni rivoluzionarie per i nostri giorni. Figuriamoci poi se allarghiamo lo sguardo alla storia delle culture altre, l’orientale prima di tutto, ma poi l’africana, l’aborigena ecc.
In campo musicale le cose non vanno diversamente, si pensi per es all’enorme influenza esercitata sulla musica “colta” occidentale da quella africana e da quella orientale (Scelsi, p es, Cage, Feldman), mentre “i rumoristi” alla Nono o alla Lachenman scambiano affinità addirittura con l’arte visiva astratta.
Infatti se consideriamo la storia dell’arte come un tutt’unico, senza entrare nella questione delle differenze che certamente sono intervenute nei vari settori specifici, le interinfluenze sono numerosissime e fecondissime: gli aborigeni influenzano Chatwin e Tremlet, il Jazz tutti i poeti americani On the road, (tanto per fare solo qualche esempio). Non mi risulta un’influenza paragonabile a quella dell’arte da parte della fiilosofia o della scienza. Il poeta in genere ascolta solo il poeta e non vuol farsi influenzare dal pensiero. Non può evitarlo, ma per lo più se ne tiene lontano. Forse lo respira nell’aria comune, perché la sua curiosità per il prossimo, la società, l’immaginario collettivo è somma, ma ascolta prima di tutto il collega. Magari di un’altra parrocchia.
Credo quindi che nella critica d’arte sia necessario un chiarimento preventivo: il critico maggiormente patentato a parlare d’arte (dico parlare nello stretto senso della parola), con tutti i limiti dei suoi paraocchi (spiegherò in seguito l’uso di questo sostantivo), è l’artista e solo successivamente lo studioso della materia, lo storico dell’arte. Fino ad oggi la complessità della materia e negli ultimi decenni la dilatazione abnorme del parco operatori hanno costretto il senso comune e gregario a indicare costoro come i principali detentori di un’improbabile verità, proprio perché non si fida, non si è mai fidato dei paraocchi che indubbiamente condizionano la ricerca del singolo artista. Infatti gli artisti, per la specificità e, in un certo senso, la tirannia esercitata dalla loro ricerca, peccano tutti, più o meno, di parzialità e quindi giustificano il senso comune, ma hanno anche un paio di qualità che nessun altro soggetto coinvolto possiede: la generosità e l’onestà intellettuale. Chi manovra l’arte è condizionato da questa, formato, istruito, educato da questa, prima di tutto col linguaggio elettivo, ma poi con tutti gli altri: l’artista vive essenzialmente di arte e l’ultima delle sue preoccupazioni è l’economia. La sua “generosità” deriva dalla gratitudine per chi, attraverso la sua lingua, ma in generale, lo ha aiutato a tirare un sospiro di sollievo di fronte alle magagne del mondo: ha trovato un fratello; l’”onestà intellettuale” è condizione di qualsiasi creazione originale e seria.
Se ci abituiamo a questo approccio se non in sostituzione, per lo meno in anticipo su quello filosofico, storico, sociologico ecc, potremmo avere molte sorprese. Comunque, a mio avviso, un’attenzione maggiore alle vicende dell’arte e anche alle poetiche degli artisti aiuterebbe a riscrivere quella della storia tout court, per la quale la parola chiave è sempre fondamentalmente Vendetta.