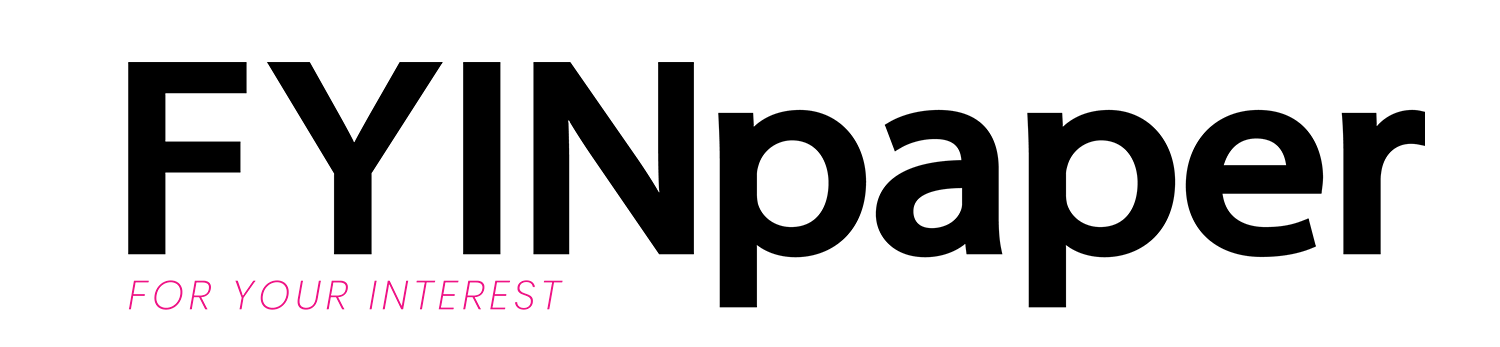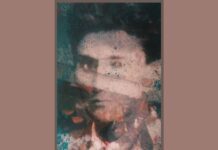Abstract: A system is complex when non-linear relationships exist between its elements. The non-linear system never reaches a static but a dynamic fluctuating equilibrium, in addition to producing emerging effects of evolutionary innovation, since the system is greater than the sum of its constituent parts. The complex dynamic system is also adaptive, as it self-organizes its conservation with feedback chains that keep its internal environment in balance with the external environment. For its self-preservation, the system tends to homeostasis, that is, to maintain constant values in its internal environment, values that it maintains fluctuating in the internal space delimited by defined critical thresholds, regard- less of the pressure of variations in the external environment. An example is the maintenance of the body’s health temperature in the fluctuating equilibrium within internal critical thresholds located between 36° and 37°. In the internal environment of the organism, the critical thresholds defend against temperature variations in the external environment, while they allow in the internal space limited by critical thresholds, various possible fluctuating equilibria of a reversible and circular type of individual health temperatures. To show that this model of reversible fluctuating equilibrium in space between critical thresholds has a general value for complex adaptive dynamical systems, this study shows its application possibilities in several significant fields of science, notably in the ethical, social, physical, biological, psychological, ecological, cosmological field.
Sunto: Un sistema è complesso quando tra i suoi elementi esistono relazioni non lineari. Il sistema non lineare mai raggiunge un equilibrio statico ma dinamico fluttuante, oltre produrre effetti emergenti di innovazione evolutiva essendo il sistema non lineare superiore alla somma delle sue parti costituenti. Il sistema dinamico complesso è anche adattivo, in quanto autorganizza la sua conservazione con catene di retroazione che tengono in equilibrio il suo ambiente interno con l’ambiente esterno. Per la sua autoconservazione il sistema tende alla omeostasi, ovvero a mantenere costanti i valori nel proprio ambiente interno, valori che mantiene fluttuanti nello spazio interno delimitato da definite soglie critiche, qualunque sia la pressione delle variazioni dell’ambiente esterno. Un esempio è il mantenimento della temperatura della salute corporea nell’equilibrio fluttuante entro soglie critiche interne collocate tra 36° e 37°. Nell’ambiente interno dell’organismo le soglie critiche difendono dalle variazioni di temperatura dell’ambiente esterno, mentre consentono nello spazio interno limitato da soglie critiche, vari possibili equilibri fluttuanti di tipo reversibile e circolare di temperature individuali della salute.
Per mostrare che questo modello dell’equilibrio fluttuante reversibile nello spazio tra soglie critiche ha un valore generale per i sistemi dinamici complessi adattivi, questo studio ne mostra le possibilità di applicazione in numerosi campi significativi delle scienze, segnata- mente in campo etico, sociale, fisico, biologico, psicologico, ecologico, cosmologico.
Citazione: Sciarra E., Per un modello generale dell’equilibrio nei sistemi dinamici complessi adattivi, «ArteScienza», Anno XI, N. 21, pp. 5-18, DOI:10.30449/AS. v11n21.186.
1 – Paragrafo
Nel presentare un mio modello epistemologico dell’equilibrio nei sistemi dinamici complessi, intendo adottare sia il criterio di libertà del metodo sia il criterio di contingenza del sapere di Paul Feyerabend, forse il più grande epigono di Popper.
Epistemologo e storico della scienza tra i maggiori, Feyerabend (2002) ritiene che il sapere procede astraendo dall’esperienza e riducendo il mondo a formule che modellano la realtà, la quale invece ha una abbondanza inesauribile, una ridondanza irriducibile ad ogni formula o legge. Il sapere è contingente perché nessuna formula o modello esaurisce la realtà. Come diceva Popper (2010) la ricerca non è mai definitiva, perché ogni ricerca è selettiva, è storicamente valida a parità di condizioni di riproducibilità intersoggettiva, secondo la clausola coeteris paribus che accompagna ogni legge, legge che è sempre falsificabile con una critica autocorrettiva senza termine, ogni volta che i limiti storici dati alle teorie ipotetiche e agli esperimenti empirici mostrano di cedere all’abbondanza del reale presentando anomalie. Allora si assiste ad una rivoluzione scientifica nell’accezione di Kuhn (2009), che costringe a cambiare paradigma della scienza storica precedente con un nuovo paradigma innovativo più ampio, che immette un nuovo equilibrio che ricomprende e limita gli errori delle visioni scientifiche precedenti.
Feyerabend (1979, 2024) rivendica inoltre alla scienza una capacità creativa che si sviluppa sottraendosi ad ogni autorità, sia delle scuole sia della stessa ragione, perché ha bisogno di una libertà senza dipendenze da metodi già codificati e forme conoscitive predefinite per raggiungere l’innovazione nella scoperta. La ricerca può giovarsi in modo libero della ragione deduttiva come delle intuizione, della fantasia come dei dati sensibili, dell’esperienza vissuta come del sapere comune, delle visioni metafisiche come delle metafore del mito, nella libertà più piena per poter elaborare conoscenza scientifica originale.
2 – Paragrafo
Nella ricerca che presento di un mio modello di equilibrio nei sistemi dinamici complessi, intendo presentare un modello generale applicabile ai sistemi delle discipline umanistiche come ai sistemi delle discipline naturalistiche, combinando la dimensione ermeneutica umanistica con la dimensione analitica scientifica, secondo la teoria unificata del metodo di Antiseri (2001). Applicando il criterio di contingenza di Feyerabend al mio modello di equilibrio, occorre dichiarare in via preliminare: a.) che certamente il mio modello di equilibrio non coglie tutta la realtà ridondante dei sistemi complessi, ma la coglie in modo selettivo con l’astrazione ritagliando alcune caratteristiche dei sistemi e trascurandone altre, b.) che il mio modello mostra una sua validità nei limiti in cui consente la sua riproducibilità intersoggettiva a parità di condizioni, c.) che il mio modello è sempre suscettibile di falsificazione mostrando anomalie da correggere di fronte all’abbondanza del reale che può innescare nuovi equilibri con un cambio di paradigma storico.
Applicando il criterio di libertà del metodo di Feyerabend alla mia ricerca di un modello di equilibrio sistemico, utilizzerò le fonti più diverse sia umanistiche che scientifiche, selezionandole dall’antichità alla contemporaneità per individuare i tratti comuni persistenti.
3 – Paragrafo
Inizio col prendere in considerazione il principio di equilibrio affermatosi nella cultura sapienziale antica, che tanta influenza ha esercitato sugli sviluppi della cultura occidentale ed oltre. Nel tempio di Apollo a Delfi era inciso un motto comune a tutta la sapienza e la saggezza greca. Il motto recitava “nulla di troppo” e individuava un modello di equilibrio come presa di distanza dagli eccessi, regola per mantenersi nell’intervallo del giusto mezzo, senza oltrepassare il limite di una soglia critica che faceva violenza all’equilibrio. Si trattava anzitutto di un modello di equilibrio etico, secondo cui la virtù sta nel mezzo, come medietà tra due vizi, quello dell’eccesso e quello del difetto (Aristotele, 2000), modello umanistico che pensava di rispettare secondo natura anche il modello dell’equilibrio fisico della natura.
Una concreta rappresentazione comportamentale e situazionale del modello di equilibrio etico umanistico come fisico naturale an- nunciato a Delfi, viene in evidenza dalla ricostruzione in versione sistemica del mito del volo di Icaro, letto secondo le regole analitiche del padre Dedalo. Dedalo grande architetto ed inventore, per fuggire dal labirinto cretese e poter tornare ad Atene, costruisce per sé ed il figlio Icaro delle ali con penne e cera. Dedalo raccomanda a Icaro di non volare avvicinandosi troppo al sole perché il caldo eccessivo scioglie la cera delle ali, e neanche avvicinarsi troppo al mare perché l’umidità eccessiva appesantisce le piume delle ali. Per non precipitare in entrambi i casi, Icaro deve mantenersi in volo nell’ equilibrio intermedio tra due soglie critiche come limite da non superare, evitando la soglia critica verso l’alto del caldo che scioglie la cera, e la soglia critica verso il basso dell’umidità che appesantisce le piume. Dedalo lascia quindi ad Icaro un vasto spazio di possibilità di volo in tutte le direzioni contenute entro le due soglie critiche, perché l’equilibrio sistemico non è mai un punto medio statico tra gli esterni, ma uno spazio dinamico di possibilità aperte tra le soglie critiche di cui non si deve superare il limite, per non entrare in una diversa dimensione governata da altri equilibri. Se Icaro avesse seguito l’equilibrio sistemico raccomandato dal padre avrebbe salvato la vita, per non aver rispettato l’equilibrio della sua situazione sistemica, violando una soglia critica per volare troppo vicino al sole è caduto e ha persa la vita.
La metafora del mito è quanto mai sapiente nel delineare un tipico sistema complesso, dinamico, adattivo. Sistema complesso perché include varie scelte alternative di azione tra padre e figlio, tra sole e mare, tra vita e morte, in una situazione che mentre pone varie differenze oppositive, mette anche in relazione tra loro tutti gli opposti; sistema dinamico perché presenta un equilibrio di azioni multiple nello spazio di possibilità circolari delimitato dai vincoli di soglie critiche; sistema adattivo perché decisione di azione e situazione ambientale si organizzano ed adattano reciprocamente tra vincoli posti dalla natura e possibilità di azione umana.
4 – Paragrafo
Il modello di equilibrio sistemico presentato dalla cultura sapienziale antica mostra alcuni tratti da evidenziare. L’equilibrio del sistema è caratterizzato da uno stato semistabile di fluttuazioni reversibili, come equilibrio oscillante e circolare legato alle possibilità dinamiche degli elementi del sistema entro uno spazio delimitato da soglie critiche. Tali soglie quantitative e qualitative delimitano la organizzazione del sistema nel giusto mezzo adatto alla stabilità della vita del sistema, contenendo le fluttuazioni lontano da valori di eccesso o di difetto, così che quel particolare equilibrio definisce e forma le regolarità di quel sistema. Se vengono superati i valori delle sue soglie critiche il sistema crolla sia nel suo equilibrio che nelle sue proprietà, lasciando aperta la possibilità dell’emergere di nuove proprietà e nuovi equilibri, che mostrano la contingenza delle regolarità precedenti. Si assiste ad una distruzione di sistema creatrice di nuovo sistema (Foster e Kaplan, 2001)
Nel modello sapienziale antico ravvisiamo le basi di un modello generale dell’equilibrio nella moderna scienza dei sistemi dinamici complessi adattivi. Occorre quindi mettere a confronto il modello antico con casi concreti della scienza contemporanea, confronto da cui ricavare un modello epistemologico generale. Partiamo da un caso della ricerca fisica, la cui importanza è stata riconosciuta col premio Nobel in fisica nel 2001. Si tratta del condensato di Bose-Einstein (Pitaevskii e Stringari, 2003), uno dei primi nuovi stati dalla materia ad essere teorizzato al di fuori di quelli noti, stato solido, liquido, gassoso. La teoria di Bose ed Einstein fu elaborata sin dal 1924 agli esordi della meccanica quantistica, per vedere realizzato in laboratorio il condensato solo nel 1995. I risultati dell’esperimento mostrarono risultati sorprendenti quando si intervenne a modificare le soglie critiche modificando gli equilibri del sistema.
Nel mondo dell’estremamente piccolo della meccanica quantistica, le particelle vennero raffreddate ad una temperatura appena superiore allo zero assoluto, perdendo così proprietà dei precedenti stati di equilibrio per assumere nuove proprietà sotto nuovi equilibri. Infatti atomi ultrafreddi portati a temperature vicinissime allo zero assoluto si avvicinano tra loro a distanze mai raggiunte prima, a soli 50 nanometri, una distanza 10 volte inferiore alle precedenti. A tale distanza minima emerge un nuovo equilibrio, le particelle perdono la loro individualità per comportarsi come un unico agglomerato, quale è lo stato del condensato di Bose-Einstein, uno stato in cui i fenomeni si manifestano più come onde che come particelle.
Riscaldando nell’esperimento un primo gruppo di atomi, mentre un altro gruppo veniva separato da un vuoto senza alcun contatto diretto col primo, l’esperimento evidenziò con sorpresa che il calore passava dal gruppo riscaldato a quello freddo attraverso il vuoto, mentre normalmente in fisica il passaggio di calore esige un contatto diretto.
Nel nuovo stato della materia del condensato di Bose-Einstein, l’esperimento modifica alcune soglie critiche, portando la temperatura prossima allo zero assoluto, costringendo gli atomi a distanza ravvicinata mai raggiunta. Allora emergono fluttuazioni tra gli elementi del sistema con nuove proprietà, nel nostro caso di onda più che di corpuscolo, così da far emergere un nuovo equilibrio di regolarità delle leggi fisiche, che ammettono il passaggio di calore anche senza contatto.
5 – Paragrafo
Non solo in fisica ma anche in biologia si va affermando un modello di equilibrio sistemico analogo. Ogni organismo vivente è considerato un sistema complesso, che si autoregola con retroazioni circolari per raggiungere l’equilibrio dinamico adattivo rispetto alle perturbazioni dell’ambiente. Per Monod, premio Nobel per la medicina del 1965, l’organismo realizza la teleonomia della sua autoconservazione, nell’equilibrio di oscillazione tra due soglie critiche, da un lato il caso fortuito da cui dipende la mutazione iniziale, dall’altro la necessità delle leggi di duplicazione genetica del nuovo carattere (Monod, 2001).
Piaget a sua volta vede la maturazione dello sviluppo biologico e mentale nell’equilibrio oscillante tra assimilazione dell’ambiente agli schemi operatori dell’organismo e poi accomodamento dell’organismo ai vincoli posti dall’ambiente, sino a raggiungere in modo fluido e reversibile uno stato di adattamento quasi stabile come equilibrio tra le due soglie critiche opposte di assimilazione ed accomodamento (Piaget, 1983).
Per i teorici della autopoiesi i sistemi viventi sono sistemi autorganizzanti, le cui trasformazioni non sono funzione degli stimoli dell’ambiente ma della capacità di autopoiesi, capacità di conservare la propria organizzazione chiusa per compensare le perturbazioni provocate dall’ambiente esterno (Maturana e Varela, 1985). In questo senso l’equilibrio biologico è un equilibrio dinamico che tende alla omeostasi, ossia a mantenere costanti valori che fluttuano nell’ambiente interno dell’organismo, autoregolando come stabili parametri funzionali alla vita dell’organismo, nonostante variazioni dell’ambiente esterno. Si pensi al mantenimento della temperatura del corpo tra 36°C e 37°C tenendo in equilibrio circolare quasi stabile valori di oscillazione tra soglie critiche per la salute del corpo rispetto alle variazioni ambientali. Si pensi alla funzione del rene che filtra e depura il nostro sangue dei prodotti di scarto del metabolismo e li espelle tramite l’urina. Attraverso la funzione di filtraggio e depurazione il rene è di fatto un equalizzatore perché mantiene l’equilibrio dei liquidi corporei, regolando la concentrazione dei soluti perché non siano troppo alti o troppo bassi, ma giusti ovvero equilibrati per il mantenimento della salute corporea.
6 – Paragrafo
Anche l’ecologia conferma un modello di equilibrio sistemico analogo. L’equilibrio ecologico della natura consiste nel mantenimento di soglie critiche tra un minimo ed un massimo di quasi stabilità delle nicchie del sistema vivente da rispettare.
Il pianeta Terra è un essere vivente interconnesso con l’uomo in reciprocità. La sostenibilità ecologica consiste nella prudenza di fermare le azioni umane di prelievo di risorse dalle nicchie dell’ambiente prima che le conseguenze distruttive del prelievo diventino irreversibili, impedendo che l’ambiente ricostituisca quelle risorse. Ad esempio posso potare un albero per prelevare rami che serviranno come risorsa per il fuoco che mi riscalda, ma devo fermarmi ad una soglia critica di potatura, la soglia che permette che l’albero ricostituisca i sui rami. La soglia critica segna il principio di precauzione di cessare la potatura prima che il prelievo diventi irreversibile cioè impedisca all’albero di ricostituire i suoi rami. Salvando la reversibilità dei processi naturali l’uomo salva la vita dell’ambiente, che a sua volta salva la vita dell’uomo che può contare su rinnovate risorse dell’ambiente. L’equilibrio di reciprocità tra uomo e natura consente un campo di possibili azioni che oscillano tra soglie critiche di sostenibilità reciproca, ma che vietano di imboccare azioni di danno irreversibile alle nicchie ecologiche, che rappresentano sottosistemi vitali interconnessi nel sistema ecologico complesso (Lovelock 2011). Se estendiamo lo sguardo di tipo ecologico dal pianeta al cosmo, possiamo incontrare un modello di equilibrio sistemico analogo.
Anche il cosmo è un sistema complesso il cui equilibrio è affidato alla tensione oppositiva e insieme complementare tra ordine e disordine, tra entropia e sintropia. Da un lato la fisica mostra che nel mondo tutto si disperde, si livella, si mescola, dall’altro lato la biologia mostra la tendenza opposta alla organizzazione, alla crescita, allo sviluppo. L’equilibrio del sistema della natura dipende da come si articola l’intreccio interattivo e complementare della doppia tendenza, sia al disordine come entropia manifestata dalla fisica sia all’ordine come sintropia manifestata dalla biologia.
Il matematico italiano Luigi Fantappiè nel 1942 propose di considerare il mondo come costituito dalla relazione tra ordine e disordine, avanzando come necessaria una prospettiva unitaria tra mondo fisico e biologico (Fantappiè 2011). Di qui la teoria di un mondo governato dalla interazione tra sintropia dell’universo come tendenza alla auto-organizzazione della natura verso la vita, in intreccio circolare con l’entropia dell’universo, come tendenza della natura alla degradazione di materia ed energia verso la morte.
L’equilibrio dell’universo si concentra sul punto Omega intorno a cui entropia e sintropia, nella loro interazione complessa tra opposti, oscillano a pendolo in un piccolo spazio di equilibrio fluido circolare, assumendo valori tra minimo -1 e massimo +1, breve intervallo della singolarità in cui si colloca circolarmente il punto d’arrivo del disordine entropico dell’universo ed il punto di inizio della riorganizzazione sintropica dell’universo. Un universo oscillante in modo circolare e reversibile tra entropia e sintropia, che conserva il sistema complesso dinamico adattivo in una pur minima asimmetria tra opposti, al fine di autoconservare un equilibrio semistabile della vita dell’universo. L’universo oscilla in circolo a pendolo tra le due soglie critiche opposte di entropia e sintropia, per evitare di oltrepassare i limiti irreversibili di una caduta unilaterale, da un lato per evitare di degradare nella entropia estrema del freddo, dall’altro lato per evitare di concentrare la sintropia in una estrema esplosione di caldo. Il premio Nobel 2020 per la fisica Roger Penrose, di fronte alla espansione di una radiazione di fondo dell’universo a partire dall’ipotesi di un Bing Bang iniziale, nella difficoltà di spiegare cosa c’era prima e cosa ci sarà dopo, avanza la teoria di una cosmologia ciclica, in cui l’universo evolve in un’infinita successione di fasi in cui la fase finale di un ciclo coincide con l’inizio di quello seguente (Penrose, 2023).
L’equilibrio dell’universo si mantiene in tal modo autorganizzante e stabile con una piccola oscillazione pendolare nel punto di incontro tra le due soglie critiche di entropia e sintropia. L’universo fluttua in modo circolare e reversibile, evitando sia la tendenza al troppo caldo che lo riporterebbe al Big Bang iniziale, sia la tendenza al troppo freddo che lo porterebbe alla morte termica finale.
7 – Paragrafo
Tutti i classici della contemporanea teoria dei sistemi, da Prigogine (1981) a Bertalanffy (2004), da Varela (1979) a Morin (1993), distinguono tra sistemi lineari e sistemi complessi.
Un sistema lineare ha proprietà additive, secondo cui l’effetto di un insieme di elementi che costituisce il sistema, è la semplice somma degli effetti considerati separatamente negli elementi.
Invece un sistema complesso presenta proprietà emergenti, secondo cui l’insieme del sistema ha proprietà nuove superiori alla somma delle proprietà degli elementi. Un sistema complesso non è lineare, procede per salti discontinui, raggiunge un equilibrio com- plesso in cui l’intero è superiore alle parti, sviluppando un equilibrio fluttuante dei suoi elementi con proprietà diverse e oppositive in uno spazio delimitato da soglie critiche.
L’equilibrio di un sistema complesso resta quasi stabile quanto è contenuto entro soglie critiche, consentendo alcune regolarità. Ma queste regolarità sono contingenti, perché se si oltrepassano le soglie critiche emergono nuove proprietà e nuove regolarità, diverse dalle precedenti, e su questa diversità si costituisce un nuovo equilibrio fluttuante tra nuove soglie critiche.
Un sistema nasce come una struttura organizzata prodotta dalla cooperazione di molti elementi singoli. In un sistema complesso, dinamico, adattivo, la struttura del sistema interagendo con l’ambiente interno ed esterno si autorganizza e si sviluppa con catene di retroazioni evolvendo verso livelli di ordine e complessità emergenti. L’emergenza è la irriducibilità del sistema agli elementi costituenti, anche se gli elementi sono altri sistemi, in una stratificazione di sottosistemi interconnessi a livelli crescenti, tutti con proprietà nuove e irriducibili. Il livello emergente nasce da un salto discontinuo perché nel cambiamento nel sistema complesso, dinamico, adattivo, sono state superati gli equilibri delle soglie critiche del livello precedente. Complessità significa introduzione di sistemi multidimensionali costituiti dai dualismi antagonisti di ordine e disordine, caso e necessità, uguaglianza e differenza, chiuso e aperto, finito e infinito, riducibile e irriducibile, continuo e discontinuo, ordine e caos, lineare e frattale (De Angelis, 1996; Waldrop 1996; Mandelbrot, 2000; Bocchi e Ceruti, 2007).
Per riproporre in una sintesi finale un mio modello generale di equilibrio nei sistemi dinamici complessi adattivi, attraverso un modello epistemologico dell’equilibrio fluttuante reversibile nello spazio tra soglie critiche, utilizzeremo la prospettiva della teoria dei giochi di Wittgenstein (2009), interpretata nelle categorie sistemiche complesse del dualismo tra vincoli e possibilità di Ceruti (2009).
Wittgenstein sviluppa una sua teoria di gioco nei linguaggi e nelle regole di azioni nelle forme di vita socioculturali, come giochi che si articolano tra vincoli e possibilità. Un gioco tra vincoli e possibilità può essere semplificato nel tennis. Le regole del tennis presentano vincoli che nel campo di gioco diventano soglie critiche da non superare, consentendo però entro lo spazio di quei vincoli di un sistema complesso di gioco di sviluppare liberamente tutte le possibili mosse lasciate alla scelta di ogni giocatore, secondo un equilibrio fluente e reversibile che si sviluppa tra i giocatori interconnessi da interazioni circolari. Un vincolo per ogni singolo giocatore è la regola che ribattendo la palla deve sempre superare la rete e far cadere la palla entro il campo dell’avversario delimitato dopo la rete. Ma nessuna regola dice quanto in alto e con quanta forza debba passare la palla sopra la rete, ed in quale spazio nel campo dell’avversario debba cadere la palla, lasciando alle illimitate possibilità di scelta di ogni giocatore di sviluppare il flusso circolare delle interazioni creative tra giocatori, che in ogni momento in quelle regole devono trovare un equilibrio fluttuante reversibile per reggere il sistema entro le soglie critiche del sistema complesso del gioco.
Bibliografia
Antiseri D. (2001). Teoria unificata del metodo. Torino: UTET.
Aristotele (2000). Etica Nicomachea. Milano: Bompiani.
Bertalanffy L. von (2004). Teoria generale dei sistemi. Milano: Mondadori.
Bocchi G. e Ceruti M. (cur.) (2007). La sfida della complessità. Milano: Bruno Mondadori.
Ceruti M. (2009). Il vincolo e la possibilità. Milano: Raffaello Cortina Editore.
De Angelis V. (1996). La logica della complessità. Introduzione alle teorie dei sistemi. Milano: Bruno Mondadori.
Fantappiè L. (2011). Che cos’è la sintropia. Principi di una teoria unitaria
del mondo fisico e biologico e conferenze scelte. Roma: Di Renzo.
Feyerabend P. K. (1979, 2024). Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza. Milano: Feltrinelli.
Feyerabend P. K. (2002). Conquista dell’abbondanza. Storie dello scontro fra astrazione e ricchezza dell’essere. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Foster R.N. e Kaplan S. (2001). La distruzione creatrice. Milano: Etas.
Kuhn T.S. (2009). La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Torino: Einaudi.
Lovelock J. (2011). Gaia. Nuove idee sull’ecologia. Torino: Bollati Boringhieri.
Mandelbrot B. B. (2000). Gli oggetti frattali. Torino: Einaudi.
Maturana H. R. e Varela F. J. (1985). Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente. Venezia: Marsilio.
Monod J. (2001). Il caso e la necessità. Milano: Mondadori.
Morin E. (1993). Introduzione al pensiero complesso. Milano: Sperling & Kupfer,
Penrose R. (2023). Dal Big Bang all’eternità. I cicli temporali che danno forma all’universo. Milano: Rizzoli.
Piaget J. (1983). Biologia e conoscenza. Torino: Einaudi.
Pitaevskii L. and Stringari S. (2003). Bose-Einstein Condensation.
Oxford: Oxford University Press.
Popper K.R. (2010). Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza. Torino: Einaudi.
Prigogine I. e Stengers I. (1981). La nuova alleanza. Torino: Einaudi.
Waldrop M.M. (1996). Complessità: uomini e idee al confine tra ordine e caos. Torino: Instar Libri.
Wittgenstein L. (2009). Ricerche filosofiche. Torino: Einaudi.
A collaboration with ArteScienza (direttore Luca Nicotra), XI, 2024, June, n.21, ISSN 2385-1961
Ezio Sciarra
profesore Ordinario di Filosofia della scienza e di Sociologia generale, lunga carriera universitaria con rilevanti incarichi di responsbailità (Preside della Facoltà di Scienze Sociali – Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, ecc.). Fondatore e direttore di riviste scientifiche (Ratio Sociologica, ecc.), Vari contributi tra epistemologia e scienze sociale cona particoalre attenzione a Kr Poppere, numersosi saggi in volumi suoi e collettanei.