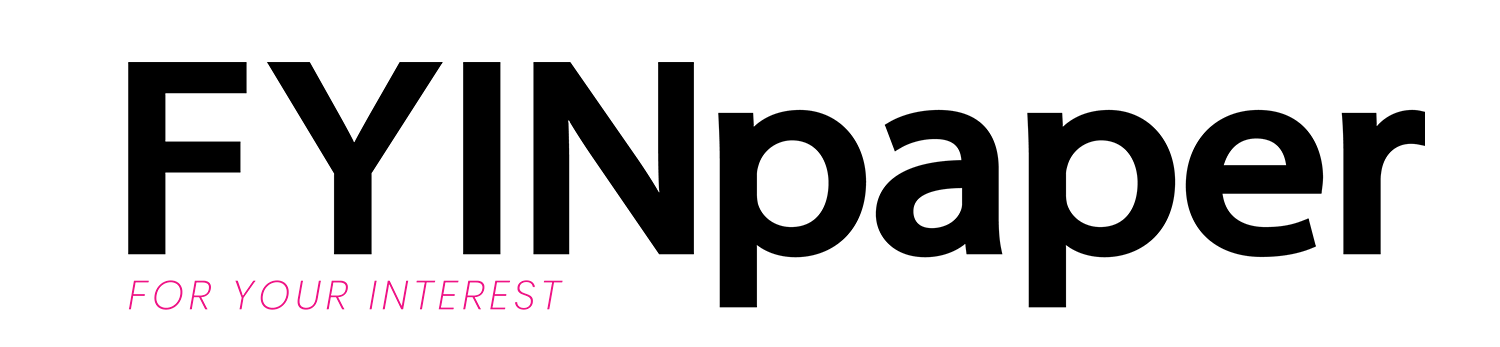Giovanni Michelucci non solo è vissuto cent’anni ma, con la sua Fondazione ha voglia di vivere ancora, come dimostra la celebrazione dei trent’anni dalla sua morte che essa si appresta a fare.
Continua a vivere anche il mito del “grande Architetto” che i Fiorentini hanno inventato, evidentemente immemori dei veri e grandissimi architetti della storia di Firenze.
C’è, a dir il vero, un’opera che potrebbe meritare questa valutazione: è la Stazione di Firenze, un’opera di schietta modernità, che è veramente bella, ma è di Michelucci? Non proprio, anche se egli sembra essere stato il solo ad averne gli onori, poiché sono rimasti un po’ in disparte gli altri membri del “Gruppo Toscano” che avevano lavorato sul progetto, un gruppo di giovani architetti, tutti sui ventisette anni mentre Michelucci ne aveva quarantuno e quindi, per ragioni anagrafiche, era capofila del gruppo. Un’opera in cui si sente il vigore e l’entusiasmo della giovinezza.
Quanto al “grande architetto”, che sarebbe, dicono, anche un poeta, si dovrebbe poter vedere in quest’opera un primo segno del suo stile, che le opere successive avrebbero confermato e sviluppato. Invece esse sono banalissime, per non dire brutte, nulla in comune con il capolavoro della Stazione.
Passando oltre la Cassa di Risparmio di Firenze, che mi sembra appunto abbastanza banale, l’orribile grattacielo di Livorno e la Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi di Firenze che ha finito di rovinare la Via Pietrapiana, già ferita da precedenti demolizioni, eccoci all’altro “capolavoro”: la Chiesa dell’Autostrada del Sole, che mi sembra un compendio non tanto delle opere precedenti quanto degli innumerevoli schizzi che l’architetto ci ha lasciato. Essi ci mostrano il misterioso substrato psicologico di un uomo ossessionato da una confusione interiore simile a un’intricatissima foresta, da cui cerca di districarsi cercando e creando dei puntelli, proprio come quelli che si vedono nella Chiesa e in altre sue opere. Spesso essi sono come alberi, presi dalla natura di cui era un vero amante, ma di cui non ha forse colto interamente la bellezza e l’equilibrio.
Che distanza e anzi che incredibile diversità e estraneità rispetto al limpido progetto della Stazione che, oltre ad essere di tanti anni prima, non faceva evidentemente parte del suo mondo. Ma che distanza anche da un retto sentire, tanto religioso quanto architettonico, da cui l’architetto si è allontanato. Forse, guardando a Rochamp, si credeva un nuovo Le Corbusier? Certo si è allontanato dalla misura toscana a cui avrebbe dovuto attenersi, come ha fatto in opere minori e non ossessionate dalla fama di essere considerato un “grande architetto”.
Non conosco i suoi scritti sulla città, di cui anche la sua Fondazione si occupa, e mi limito a sperare che essi siano di un più alto livello rispetto ai confusi schizzi che ha dedicato alla ricostruzione del quartiere del Ponte Vecchio, che poi è stata fatta in un modo non meno “penoso”, che anch’egli ha giustamente criticato.
Purtroppo la Firenze che si gloria della sua opera non è più quella dei secoli d’oro in cui c’erano ben altre opere di cui gloriarsi. Non solo la Fondazione, creata da Michelucci stesso, ma il Comune di Firenze, la Regione Toscana e la Cassa di Risparmio sono concordi nel sostenerne il mito,come se ciò fosse sufficiente per far dimenticare la mediocrità del presente.
Un mito che mi sembra quindi da ridimensionare, con tutto il rispetto per l’uomo e per i suoi migliori contributi a un tempo così difficile.